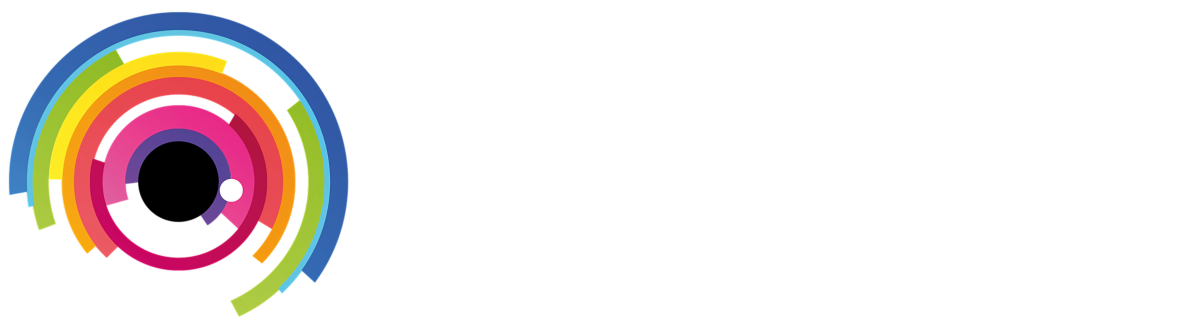Il Pride: estetica, cultura e politica
Spunti per aziende virtuose
di Roberto Rafaschieri

Roberto Rafaschieri
Consulente per la comunicazione di impresa e formatore specializzato in media digitali e tematiche DE&I. Ha co-fondato indig, realtà che si occupa di comunicazione inclusiva e accessibile.
Aiuta aziende e organizzazioni a valorizzare il proprio impegno sociale attraverso la comunicazione.
Visto “da fuori”, da chi non fa parte della comunità LGBTQ+, il Pride – sia come evento che come movimento – è spesso quantomeno frainteso.
Oggi più che mai, in un contesto sociale sempre più polarizzato in molte parti del mondo, è utile comprendere i tratti culturali che definiscono e identificano un movimento che rivendica anzitutto diritti e opportunità che mancano. Come vedremo, l’appariscenza e l’eccentricità hanno un senso che va molto oltre l’estetica.
Un piccolo e sintetico glossario, prima di cominciare:
- Orientamento sessuale: l’attrazione romantica e/o sessuale di una persona verso persone di genere diverso, dello stesso genere, o entrambe, o nessuna.
- Identità di genere: il senso intimo e personale di appartenenza a un genere (uomo, donna, entrambi, nessuno dei due), che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita.
- Cisgender: persona la cui identità di genere ha una corrispondenza col sesso assegnato alla nascita
- Transgender: persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita.
- LGBTQ+: acronimo che sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer. Il “+” include altre identità sessuali non conformi a una “norma” eterosessuale e cisgender. La sigla viene utilizzata anche in altre configurazioni (senza la Q, o senza il +, o con lettere ulteriori a esplicitare ulteriori identità che appartengono alla comunità): in questo articolo verrà utilizzata in questa configurazione.
- Queer: termine ombrello che può identificare tutte le persone nella comunità LGBTQ+. Utilizzato anche come aggettivo per indicare qualcosa relativo o afferente alla comunità.
Da dove viene il Pride
Il Pride, così come lo conosciamo oggi con le sue manifestazioni gioiose e partecipate, affonda le sue radici in un evento tutt’altro che festoso: i moti di Stonewall del 1969. A New York, in una notte di giugno, le persone queer presenti allo Stonewall Inn si ribellano all’ennesima retata della polizia, per la prima volta in modo organizzato e veemente. Quelle notti di scontri segnarono un punto di svolta. Dal primo anniversario di quei fatti, nel 1970, nasce il Pride: la commemorazione di una rivolta, un’occasione per ricordare le lotte passate e rinnovare l’impegno per i diritti civili.
E oggi?
Superficialmente, oggi potremmo pensare che essere queer sia tutto sommato ormai socialmente accettato e “normale”. La realtà, purtroppo, è diversa.
La distribuzione delle opportunità e possibilità di realizzazione nella nostra società, in Europa e in Italia – e in buona parte del resto del mondo – è del tutto ineguale, tra le persone dentro e fuori la comunità.
Ogni anno ILGA Europe, realtà internazionale che riunisce centinaia di organizzazioni LGBTQ+ in Europa e Asia, realizza la Rainbow Map, uno strumento che monitora lo stato dei diritti delle persone queer in 49 Paesi dell’Europa geografica.
La rilevazione di quest’anno, uscita a maggio, è particolarmente negativa a livello continentale: spiccano il divieto totale ai Pride imposto in Ungheria e la sentenza della Corte suprema britannica che non riconosce l’identità (e l’esistenza) delle persone transgender.
L’Italia, dal canto suo, è da anni il Paese con i punteggi peggiori in Europa occidentale, scontando soprattutto la mancanza di politiche attive a prevenzione delle discriminazioni in varie aree della vita pubblica e l’assenza di diritti paritari per le famiglie queer, come il matrimonio e le adozioni.
Eppure, spesso “da fuori” tutto ciò che riguarda il Pride viene visto come un’ostentazione fine a se stessa. Cosa c’entrano la politica e i diritti civili con parate, glitter e musica dance?
Il Pride, anche in questo caso inteso sia come movimento che come manifestazione, vive di codici e linguaggi condivisi – un po’ come accade in tutte le sottoculture.
Cultura queer
Il Pride, anche in questo caso inteso sia come movimento che come manifestazione, vive di codici e linguaggi condivisi – un po’ come accade in tutte le sottoculture.
Alla base di una parte importante dell’estetica queer c’è il drag, una forma artistica che con la sua teatralità volutamente esagerata e il suo gioco provocatorio con gli stereotipi di genere riesce a comunicare la rottura con gli schemi tradizionali, mettendo in discussione norme e ruoli prestabiliti.
Non è un caso: la cultura queer si è costruita negli anni intorno a un’estetica che è mezzo e messaggio stesso della rivendicazione socio-politica. Un canone che intreccia canali differenti, dalla moda, alla musica, passando per la performance artistica. E in cui all’interno della comunità si finisce per riconoscersi.
Il voguing – stile di danza che nasce nella comunità queer afroamericana negli anni ’80 – è forse l’esempio più interessante di come all’interno della cultura queer il senso di comunità e di appartenenza si intrecci in modo indissolubile con l’espressività corporea e con la musica. Un breve video di Vox di qualche anno fa lo racconta molto bene (sono attivabili i sottotitoli in italiano).
Il Pride oggi è tutte queste cose: è lotta politica, specialmente in contesti dove i diritti fondamentali sono ancora negati o sotto attacco; è affermazione di sé, del proprio essere come individui e come comunità, in un modo autentico, visibile e senza vergogna. Anche con l’eccentricità, con un’estetica che può piacere o non piacere – non è importante; è importante il messaggio. E cioè che la vera accettazione non può essere condizionata all’adeguamento a una norma arbitraria di “rispettabilità”. L’idea che “la tua identità va bene solo se la esprimi in modo conforme e discreto” è, in fondo, una forma sottile di non accettazione. Il Pride, al contrario, rivendica il diritto di esistere in pienezza, senza filtri e senza chiedere permesso.
E le aziende?
Il recente ostruzionismo del governo statunitense alle politiche di Diversity Equity & Inclusion (DEI) non è stato privo di conseguenze anche sulle scelte delle aziende di tutto il mondo di supportare economicamente i Pride – nel contesto di un generale ridimensionamento delle politiche di inclusione.
Il contesto americano da questo punto di vista è comunque diverso da quello italiano. Oltreoceano la radicalizzazione delle posizioni politiche ha portato a un’attuazione a volte percepita come “intransigente” delle politiche DEI. In Italia le riflessioni sul tema sono arrivate forse in modo più lento e cauto, ma anche più solido. E in Italia infatti non abbiamo ancora assistito a un abbandono di massa delle iniziative DEI.
Proprio in virtù del fatto che negli USA il repentino cambio culturale ha mostrato la volatilità e l’inconsistenza degli ideali di inclusione professati da molte realtà, questo scenario rappresenta per tutte le organizzazioni un’opportunità di dimostrare la genuinità del loro impegno nel creare ambienti di lavoro inclusivi e accoglienti, contribuendo anche, al di fuori delle proprie mura, alla costruzione di una società più giusta e aperta, nella quale ogni persona possa esprimersi liberamente, godere delle stesse opportunità e sentirsi pienamente sé stessa.