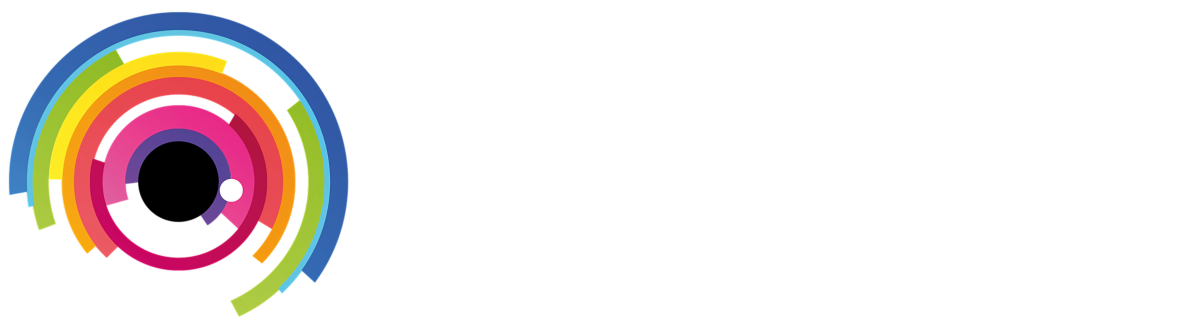Decostruire il potere
Ricostruire la leadership
di Alessia Dulbecco

Alessia Dulbecco
Pedagogista, formatrice e scrittrice specializzata in ambito DE&I. Dopo un decennio di attività all’interno di Centri Antiviolenza in Liguria e in Toscana, è attualmente freelance e si occupa di condurre formazioni, interventi e workshop all’interno di scuole, aziende e associazioni con il fine di contrastare stereotipi di genere e discriminazioni.
I suoi articoli appaiono su The Italian Review, L’Indiscreto, il Tascabile, The vision, thePeriod e altre testate culturali. È coautrice per Prospero Edizioni e D editore.
Nel 2023 ha pubblicato il suo primo saggio, Si è sempre fatto così! Spunti per una pedagogia di genere, con Edizioni Tlon, mentre è del 2025 Il piacere sovversivo. Breve storia della masturbazione, sempre per Edizioni Tlon.
Decostruire il potere è sempre difficile. Quando, lo scorso anno, Elon Musk ha iniziato a esporsi nel dibattito politico americano, mostrando apertamente di abbracciare posizioni conservatrici e sostenendo la candidatura di Donald Trump (per la cui amministrazione avrebbe successivamente ricevuto l’incarico di guida del DOGE, Dipartimento per l’efficienza governativa), gran parte dei media non ha messo in discussione il suo ruolo di riferimento globale nel mondo dell’innovazione. Al contrario, si è rinsaldato un immaginario già noto: quello del genio visionario, dell’imprenditore solitario che osa, guida, infrange le regole per produrre innovazione. Le sue intemperanze comunicative, le decisioni drastiche, persino i momenti di evidente instabilità sono stati spesso assorbiti e reinterpretati come segnali di carisma, audacia, leadership.
Ma da dove nasce l’idea che un leader debba essere così? Quando abbiamo cominciato ad associare la capacità di guidare al coraggio individuale, alla forza assertiva, alla distanza dalle emozioni? E perché tutto questo è sempre raccontato al maschile?
L’idea di leadership che domina ancora oggi in molti contesti – economici, politici, aziendali – ha radici profonde e tutt’altro che neutre. A partire dai primi del Novecento, la figura del leader si è radicata in quella dell’individuo capace di esercitare influenza, prendere decisioni rapide, incarnare una visione in grado di produrre cambiamento. È in particolare con il sociologo Max Weber che si afferma il modello del carisma come una delle possibili forme di legittimazione del potere – accanto a quella tradizionale e a quella razionale-legale – ciascuna funzionale a diversi tipi di ordine sociale. Nel caso della leadership carismatica, il leader è colui che si distingue, che si impone non per regole o ruoli formali, ma per una qualità personale quasi eccezionale. Questa idea, ripresa e rielaborata nel secondo dopoguerra da teorici come James MacGregor Burns o Warren Bennis, viene progressivamente tradotta in manuali, percorsi formativi e pratiche manageriali. Il leader efficace è quello che guida, motiva, risolve, decide. È razionale, assertivo, competitivo. Agisce con sicurezza anche nell’incertezza.
È impossibile non osservare come i tratti che connotano il "leader" siano anche quelli che caratterizzano il modo di concepire la maschilità dominante: forza, autonomia, visione strategica, controllo.
Non è un caso se le immagini più ricorrenti della leadership – dalla copertina di Forbes al cinema d’impresa – ritraggono figure maschili, spesso bianche, adulte, in abiti formali, impegnate in ruoli apicali. La leadership, così concepita, non è solo una funzione organizzativa: è un codice simbolico, un archetipo culturale, un’idea di potere incarnata in corpi specifici.
Privilegiando quei tratti associati alla maschilità dominante e costruendo attorno a essi un canone di autorevolezza difficile da mettere in discussione, il modello – apparentemente neutro – si è rivelato in realtà escludente. Ma cosa accade quando la leadership si manifesta in forme differenti? Quando è relazionale, orientata all’ascolto, capace di includere l’incertezza? Spesso viene sminuita, percepita come debole, “non adatta” a contesti competitivi. È il meccanismo del “doppio standard di genere”, che porta a rifiutare una manager se manifesta un atteggiamento rigido o autoritario ma a premiare un collega per le stesse caratteristiche, interpretate come segni di autorevolezza.
Negli ultimi anni, tuttavia, si stanno affermando visioni alternative. Studi come quelli di Amanda Sinclair invitano a pensare la leadership non come un’identità fissa, ma come una pratica situata, che cambia a seconda dei contesti e delle relazioni. In questa prospettiva, il genere non è una qualità da bilanciare, ma una lente da rimuovere. Il punto, cioè, non è opporre al modello maschile un modello femminile, ma liberare la leadership dai binarismi, e riconoscere che l’efficacia non dipende da chi sei, ma da cosa fai, come e con chi. Modelli come quello della connective leadership, teorizzato da Jean Lipman-Blumen, mostrano che guidare non significa imporsi, ma creare connessioni, valorizzare competenze diverse, tenere insieme visione strategica ed empatia. Allo stesso modo, Robin Ely, Herminia Ibarra e Deborah Kolb propongono di pensare la leadership non a partire dalle caratteristiche individuali, ma dalla relazione tra chi guida, il contesto e gli obiettivi condivisi.
Se smontiamo i tratti che per decenni abbiamo associato all’idea di leader, possiamo iniziare a costruire una figura nuova, più adatta alla complessità del presente. Una figura che incarna quell’ideale che già negli anni Ottanta la psicologa femminista Carol Gilligan tratteggiava attraverso l’etica della cura: una pratica fondata sull’ascolto, la responsabilità e la capacità di tenere conto dell’Altro. Forse è proprio questa, oggi, la qualità più radicale che possiamo chiedere a chi guida: non affermarsi, ma prendersi cura – delle persone, degli ambienti, delle relazioni che rendono possibile ogni forma di organizzazione.