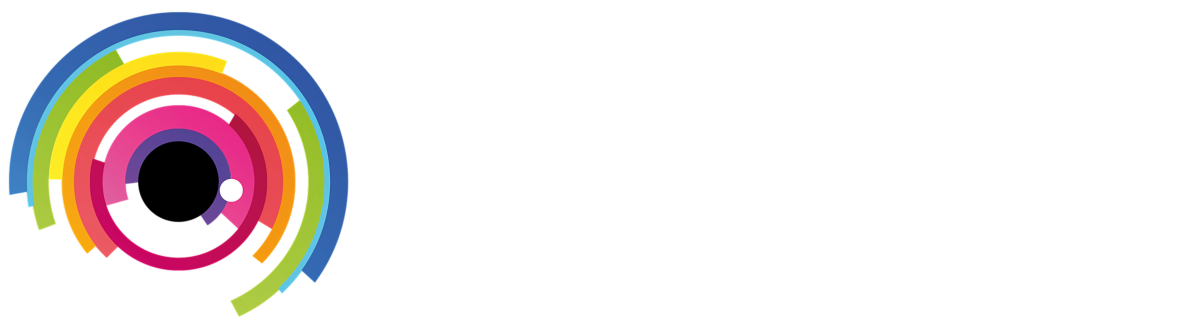Diversity e giustizia sociale
Perché le politiche di inclusione contano davvero
di Alessia Dulbecco

Alessia Dulbecco
Pedagogista, formatrice e scrittrice specializzata in ambito DE&I. Dopo un decennio di attività all’interno di Centri Antiviolenza in Liguria e in Toscana, è attualmente freelance e si occupa di condurre formazioni, interventi e workshop all’interno di scuole, aziende e associazioni con il fine di contrastare stereotipi di genere e discriminazioni.
I suoi articoli appaiono su The Italian Review, L’Indiscreto, il Tascabile, The vision, thePeriod e altre testate culturali. È coautrice per Prospero Edizioni e D editore.
Nel 2023 ha pubblicato il suo primo saggio, Si è sempre fatto così! Spunti per una pedagogia di genere, con Edizioni Tlon, mentre è del 2025 Il piacere sovversivo. Breve storia della masturbazione, sempre per Edizioni Tlon.
Negli Stati Uniti, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le politiche aziendali dedicate a promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione stanno subendo un contraccolpo violento.
Meta, una delle prime big tech a investire su programmi DE&I, ha recentemente annunciato l’azzeramento dei propri piani interni volti a valorizzare, in chiave inclusiva, ogni azione in termini di assunzioni, scelta dei fornitori e formazioni. A farne le spese non sono solo le pratiche organizzative o i framework operativi, ma l’idea stessa che la giustizia sociale possa essere discussa nei luoghi di lavoro. Una scelta che non riguarda pertanto solo l’organizzazione interna, ma manda un messaggio preciso a livello sociale: si può rinunciare a perseguire l’inclusione, se diventa scomoda. Sotto accusa non c’è una strategia aziendale, ma il principio secondo cui valorizzare le differenze non sia solo opportuno, ma necessario. E se oggi in America si mette in discussione la legittimità di una cultura inclusiva, non è improbabile che – domani – lo stesso possa accadere anche qui.
In Italia, il discorso sulla diversity è arrivato più tardi, spesso non per convinzione interna ma per imitazione o spinte esterne. Sono state soprattutto le sedi italiane di grandi multinazionali, sotto la guida delle case madri estere, a introdurre nei contesti locali le prime politiche strutturate di DE&I. Un processo a tratti forzato, più legato alla necessità di allinearsi a standard globali che a un reale cambiamento culturale. Eppure, qualcosa si è mosso: negli ultimi anni, anche nelle aziende del nostro paese si sono affacciate nuove sensibilità, si è cominciato a parlare di bias inconsci e dei loro effetti, di linguaggio ampio, di accessibilità. Ma proprio perché questo cambiamento risulta ancora disomogeneo – spesso legato alla volontà di singole figure interne – il rischio che venga messo in discussione o interrotto è ancora più alto.
In Italia, le tendenze che si respirano oltreoceano potrebbero smantellare un percorso che non ha ancora avuto il tempo di consolidarsi.
Per il mondo del lavoro, continuare a investire in una cultura inclusiva costituisce, prima ancora che una scelta etica, una strategia lungimirante. Secondo l’indagine Delivering through diversity promossa da McKinsey, le aziende con team dirigenziali etnicamente diversificati hanno il 33% di probabilità in più di ottenere risultati finanziari superiori rispetto alla media, mentre quelle con una maggiore presenza femminile nei ruoli apicali sono più redditizie del 21%. Una ricerca della Boston Consulting Group ha evidenziato che le imprese con una forza lavoro diversificata generino il 19% in più di ricavi da innovazione. Come mostra un’analisi pubblicata su Harvard Business Review, le organizzazioni che promuovono stili di leadership inclusivi – basati sull’ascolto attivo, sull’equità nei processi decisionali e sulla valorizzazione delle differenze individuali –risultano essere maggiormente in grado di attrarre talenti, rispondere ai cambiamenti e accedere a nuovi mercati. La diversità nei contesti aziendali, insomma, è una risorsa solo se riconosciuta, accolta e promossa concretamente.
Per fare in modo che le azioni sostenute dalle imprese abbiano un impatto reale, capace di superare l’ambito lavorativo, devono tuttavia situarsi dentro un contesto culturale che riconosca la diversity non solo come una strategia di posizionamento, ma come una questione di giustizia sociale. Nessun piano aziendale, per quanto ben strutturato, può funzionare davvero se si muove in un ambiente che tollera – o peggio, legittima – esclusione, disuguaglianze e stereotipi. Promuovere l’equità significa agire su più livelli: cambiare policy, ma anche linguaggi, immaginari, narrazioni. È in questo intreccio tra cultura e organizzazione che si misura la coerenza di un’impresa: nella capacità di restituire valore alla differenza non tanto perché conviene, ma perché è giusto.
Lo sottolinea con chiarezza il divulgatore Fabrizio Acanfora: parlare di inclusione significa, per prima cosa, interrogarsi su quali siano le regole implicite che governano i contesti lavorativi, chi le ha scritte, e quali corpi, identità o esperienze continuano a restarne ai margini. L’inclusione, scrive Acanfora, non può limitarsi ad accogliere chi è “diverso” in un sistema già dato, ma deve mettere in discussione le logiche stesse che hanno escluso quella diversità. In questo senso, l’impegno per l’equità non è un gesto correttivo, ma una scelta costituente. Un’impresa che vuole definirsi davvero sostenibile non può prescindere da questa riflessione: non basta adattare le strutture esistenti, bisogna avere il coraggio – politico, simbolico, organizzativo – di romperle quando non funzionano più. La vera sfida, oggi, non è includere, ma trasformare: non solo le aziende, ma anche la cultura sociale che le attraversa.